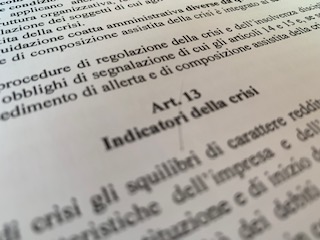Generalmente la crisi di impresa scaturisce dal comportamento degli organi societari di gestione e di controllo; talvolta, durante tale fase, questi organi commettono illeciti nel tentativo di favorire qualche soggetto o per incapacità e negligenza.
Le conseguenze di tali azioni e il relativo profilo processuale, normalmente, emergono dopo il fallimento che segue alla crisi di impresa.
Innanzitutto occorre brevemente tratteggiare la definizione di crisi di impresa, attingendo dall’art. 2 CCII (Codice della crisi e dell’insolvenza, che entrerà in vigore nel 2020): in particolare “crisi” è lo “stato di difficoltà economico finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate“.
Durante questa fase in cui gli organi societari sono chiamati a constatare lo stato di crisi ad assumere delle scelte aventi ad oggetto le modalità con cui affrontare tale condizione possono verificarsi, quindi, delle condotte illecite destinate ad assumere rilevanza una volta che l’irreversibilità del dissesto ha condotto al fallimento dell’impresa.
Quanto alla posizione dell’organo di gestione occorre distinguere tra illeciti aventi rilevanza civile e penale.
Dal primo punto di vista la società o i terzi creditori possono promuovere in sede civile un’azione di risarcimento del danno contro i membri dell’organo amministrativo che hanno posto in essere atti di gestione negligenti o dannosi per la società, violato adempimenti contabili, determinato con la loro negligenza un’insufficienza patrimoniale definitiva tale cioè da non permettere alla società di adempiere alle proprie obbligazioni.
Ad esempio la responsabilità civile degli amministratori ricorre nelle seguenti ipotesi:
- restituzione di finanziamenti erogati dai soci invece di pagare i contributi amministrativi e previdenziali, in una situazione di crisi finanziaria aziendale (Tri. Milano 10 luglio 1997);
- elargizione di finanziamenti a società già notoriamente insolventi (App. Milano 28 marzo 1980);
- iniziative ad alto rischio dopo aver acquisito solo sommarie informazioni (Trib. Reggio Emilia 12 giugno 1996);
- redazione di bilanci non rispondenti al vero per mascherare perdite di capitale (Trib. Milano 14 novembre 1993);
- sopravvalutazione del patrimonio sociale (Trib. Napoli 18 marzo 1995) o sottovalutazione per distrarre risorse sociali (Trib. Roma 24 ottobre 1985);
Da un punto di vista penalistico, invero, l’imprenditore fallito e i membri dell’organo di gestione della società fallita possono incorrere in responsabilità penale per i reati fallimentari e rispondere dei loro reati tipici:
- false comunicazioni sociali (art. 2621, 2621bis, 2621ter, 2622 c.c.);
- falso in prospetto (art. 173bis TUF);
- impedito controllo in danno ai soci (art. 2625 c. 2 e 3);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.);
- infedeltà patrimoniale (art. 2634 c.c.);
- corruzione tra privati e istigazione alla corruzione (art. 2635 e 2635bis c.c.)
- rivelazione di segreto professionale (art. 622, c. 2 c.p.)
- mendacio bancario (art. 137 c. 1 TUB);
- abuso di informazioni privilegiate (insider trading) e manipolazione del mercato (market abuse) (artt. da 180 a 187 quaterdecies TUF).
Nei casi compresi tra 1 e 12 è prevista anche una sanzione amministrativa per la società. Se la commissione dei reati indicati ai numeri 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13 da parte degli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società fallite ha cagionato o concorso a cagionare il dissesto della società, è prevista la responsabilità degli autori per il reato di bancarotta fraudolenta impropria.
Anche in relazione alla posizione dell’organo di controllo e degli incaricati della revisione legale occorre distinguere una responsabilità in sede civile e penale per le loro azioni o omissioni.
I membri dell’organo di controllo in sede civile rispondono nei confronti della società, dei soci e dei terzi:
- per violazione (con colpa o dolo) di un obbligo o di un dovere correlato al loro ufficio, se tale violazione ha provocato un danno;
- per i fatti o omissioni degli amministratori e in solido con essi, quando il danno non si sarebbe verificato se essi avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica (art. 2407 comma 2 c.c.)
In sede penale possono rispondere a titolo di concorso nei reati fallimentari o commettere alcuni reati per violazioni di doveri funzionali quali:
- false comunicazioni sociali (art. 2621 e 2622 c.c.);
- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.);
- rivelazione di segreto professionale (art. 622 comma 2 c.p.)
Possono essere individuati anche altri reati quali l’aggiotaggio (art. 2637 c.c.), l’illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.) o il falso in prospetto (art. 173bis TUF).
Quanto ai revisori legali e alle società di revisione legale:
- in caso di danni derivati dall’inadempimento ai doveri, rispondono in solido tra loro e con gli amministratori nei confronti della società che ha conferito l’incarico di revisione, dei suoi soci e dei terzi. Nei rapporti interni sono responsabili nei limiti del contributo effettivo al danno cagionato (art. 15 comma 1 D.Lgs. 39/2010). In caso di danni derivati da propri inadempimenti o da fatti illeciti il responsabile della revisione e i dipendenti che hanno collaborato alla revisione sono responsabili, in solido tra loro, e con la società di revisione nei confronti della società che ha conferito l’incarico e nei confronti dei terzi danneggiati. La responsabilità è contenuta entro i limiti del proprio contributo effettivo al danno cagionato (art. 15, comma 2, D.Lgs. 39/2010);
- Sono destinatari di una disciplina penale dei reati propri, contenuta nel TU della revisione legale (art. 27-32 D.Lgs. 39/2010), oltre a rispondere a titolo di concorso nei reati fallimentari.
Avv. Marco Napolitano