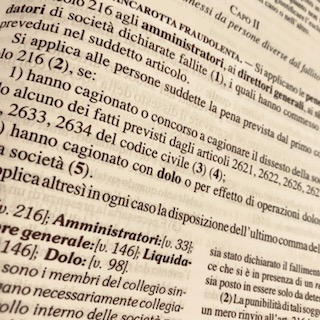Ci si chiede se accumulare continuamente debiti verso enti pubblici per l’omesso versamento dei contributi previdenziali e delle tasse rientri tra le operazioni dolose idonee a cagionare il fallimento della società. Ci si chiede quindi se l’amministratore che consapevolmente ometta di effettuare tali pagamenti ben consapevole del dissesto dell’impresa, anche qualora non voglia il fallimento della società, sia punibile per reati di bancarotta.
Risposta positiva a tali interrogativi è stata resa della recente sentenza della Cassazione Penale, sez. V, 10 gennaio 2018, n. 633. La Suprema Corte ha infatti ribadito che il mancato versamento sistematico dei contributi previdenziali rientri tra le operazioni dolose di cui all’art. 223, comma 2, n. 2 L.Fall.
Al fine di comprendere il ragionamento della Corte occorre chiarire alcuni concetti.
Come noto l’art. 223, comma 2, n. 2 R.D. n. 267/1942 (Legge Fallimentare) punisce gli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società dichiarate fallite se hanno cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il fallimento della società. Il successivo art. 224 prevede invece l’applicazione di una pena più lieve agli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società dichiarate fallite i quali violando obblighi previsti dalla legge, agendo quindi non con dolo ma con colpa, abbiano solamente concorso a cagionare o aggravare il dissesto della società causato anche da altri motivi.
Si percepisce subito che tale seconda norma punisca condotte oggettivamente e soggettivamente meno gravi in quanto le operazioni poste in essere degli amministratori non causando di per sé sole volontariamente il dissesto della società, concorrono solamente assieme ad altre diverse cause a determinare o aggravare un dissesto già in atto.
La difesa degli imputati, quindi, propendeva per affermare che la società si trovava già in stato di dissesto da molti anni e che il fallimento cui sarebbe dovuto seguire è stato procrastinato da parte degli imputati per effetto delle operazioni di elusione degli obblighi fiscali poste in essere per autofinanziarsi. Per tale ragione gli imputati non avrebbero causato dolosamente il dissesto fallimentare a causa di queste operazioni; dissesto che di certo gli imputati non volevano e non si erano prefigurati avendo come scopo quello di perpetrare e salvare la società. Invocavano quindi l’applicazione della fattispecie meno grave di cui all’art. 224 prima citato.
Ebbene, secondo l’orientamento della Suprema Corte le operazioni dolose non determinano l’interruzione del nesso di causa qualora sia preesistente un’altra causa da sola idonea a cagionare il dissesto, in quanto nel nostro ordinamento vige il principio dell’equivalenza delle concause (art. 41 c.p.); né vale a interrompere tale nesso (e quindi a escludere il reato di cui all’art. 223 L.F. in capo agli amministratori autori di operazioni dolose come l’omesso pagamento dei contributi previdenziali) il fatto che tali operazioni abbiano semplicemente aggravato un dissesto già in atto.
La giurisprudenza infatti ritiene che autofinanziarsi mediante sistematiche operazioni di omesso pagamento di contributi previdenziali e imposte costituisce un grave abuso di gestione e infedeltà ai doveri imposti dalla legge all’organo amministrativo in quanto atti intrinsecamente pericolosi per la salute economico-finanziaria dell’impresa: in altre parole tale protratto esteso e sistematico inadempimento degli obblighi verso lo Stato costituisce un’operazione in grado di aumentare ingiustificatamente l’esposizione debitoria così gravemente che l’amministratore non può non prevedere ne consegua il dissesto della società.
Per tale ragione nel caso di specie deve trovare applicazione la fattispecie di reato più grave e non già quella di cui all’art. 224 L.F.
Autofinanziare la società “risparmiando” sugli obblighi previdenziali e fiscali costituisce, quindi, una strategia molto pericolosa da cui possono conseguire pene anche fino a dieci anni.
Avv. Marco Napolitano